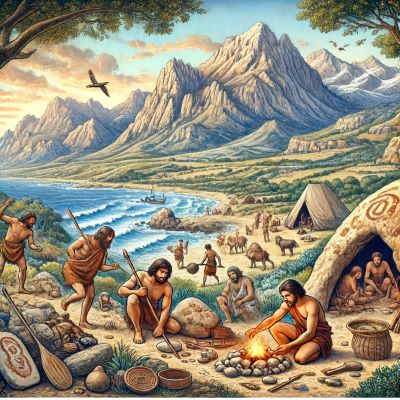Eranu a quàrchi mìgghiu di la riva di Càpu Fèdu li piscatùra di la parànza a vìla, Divina Provvidenza. Un jòrnu comu l’àutri, ddrù jòrnu. Lu cèlu, puru si allamicùsu, nun parìa avvèrsu e li cìncu marinàra, appiuncàti còmu sèmpri pì spirènzie dulurùsi, da un pèzzu travagghiàvanu smagghiànnu pìsci lucènti. Un jòrnu còmu l’àutri, ddrù jòrnu, lu sèi di màrzu di lu milliottucentunuvantasètti. Mutàngari pi nàscita, pi destinu, o pi vita vissuta, li piscatùra si muviànu senza parràri. Mirèmma lu giùvani Cicciu, di appèna diciassettànni, ma già da cìncu anni havìa canusciùtu li patimènti di stu travàgghiu, ripitìa, senza movìri lìngua, li muvimènti e l’opiràtu di lu pàtri GiuvanBattista Trinca, di cinquantaquàttru anni, di lu ziu Giusèppi Trìnca, di sessantaquàttru anni, di l’amìcu Pètru Di Marìa, di trentasètti ànni e di sò figghiu Turi, un picciutteddu di dùdici anni, ki da dùi anni stava assapurànnu li suffirènzi di la vita a màri. Un jòrnu còmu l’àutri, ddrù jòrnu.
A là ntrasàtta, na ddrù prufùnnu silènziu, un leggèru rrumùri. Vìttìru nun tàntu luntànu, davànti a ìddri, vèntu e àcqua rummuliàri, un vùrtici chì da lu màri si aisàva a muntàgna vèrsu lu cèlu.
Mmasàti, pinsàru sùbbitu a Sàntu Vitùzzu, ma li paròli nun hàppiru lu tèmpu di nèsciri di la vùcca chì, a làmpu, fòru scanniddràtì bruscàmenti e, cu un vòlu di quàrchi mètru, fòru sbattùti nà li frìddi àcqui di lu màri di màrzu. Sintìanu l’àcqua salàta sciddricàri nà lù cannaròzzu, l’òcchi sbarrachiàti bbruciàri, lù sàngu bbuttiàri, l’arìcchi fischiàri, mèntri li còrpa scinnìanu vèrsu lù fùnnu. No, no, pinsavànu, nùn haviànu allìntari. Stringèru li dènti, spingèru cù dispirazziòni cu li pèri e cu li mànu l’àcqua vèrsu lù fùnnu e, mèntri li còrpa assummàvanu, vidiànu la lùci di sùpra sèmpri cchiù vicìnu. Còmu lù sùvaru da lù fùnnu di lù màri assùmma mpituùsu all’ària e dòppu ricàdi e arrèsta a galla, accussì li piscatùra, mèntri accuminciàvanu a ccupàrisi picchì lù ciàtu cchiù unn’abbastàva, niscèru fòra dì l’àcqua all’ària disiàta e binirìtta cù là tèsta, cù li spàddri e cù lù pèttu. Lù pàtri GiuvanBattista, prìmu ancòra di pigghiàri ciàtu, mannà un ìru ngusciàtu e lòngu, Cìcciuuuu, alla ricèrca di lù fìgghiu amàtu, fìnu a quànnu nùn lù vìtti e nùn lù ntìsi tùssiri, cù l’òcchi rrùssi e cù la vùcca apèrta. Pi n’àttimu lu sò ìru s’incrucià cu chìddu dispiràtu di Petru Di Maria, Turiiiii. Talià ntòrnu. Eranu tùtti sùmmu, Cicciu, Tùri,Giusèppi, Petru, la vàrka abbuccàta, la vìla e lu timùni sfasciàti, lapàzzi e tàvuli pèrsi sùpra lu màri cuitàtu. La draunàra havìa tuppuliàtu ancòra pi addumannàri e pretènniri la sò pàrti. Cu rànni sfòrzi, li piscatùra svutàru la vàrka, jittàru fòra l’àcqua còmu mègghiu putiànu, pùru a mànu junciùti, e tintàru di pigghiàri la rìva a fòrza di rìmi. Ma la parànza, mità chìna d’acqua, ja a rilèntu e li fòrzi èranu già a la finitòria. Quànnu putiànu essìri a milli metri di la spiàggia, decisìru di abbannunàri lu mèzzu di travàgghiu, lu mèzzu pi campàri. Si mìsiru a natàri na l’àcqui agghiacciàti ki livàvanu lu ciàtu e l’enèrgia e a un cèrtu momèntu li fòrzi finèru. Li vràzza e li pèri èranu chiùmmu, lu pèttu na làstra di ghiàcciu, lu còri battìa còmu un ròggiu, la vùcca arristàva apèrta cu lù ciàtu lòngu. Nùn si muviànu cchiù li piscatùra, còmu na calamìta lu fùnnu l’attiràva, si stàvanu arrinnènnu a lù fàtu suvirchiùsu, quànnu ntìsiru vùci di spirànza:risistìti, risistìti, chì stàmu arrivànnu. Eranu li finanzèri di ddrà casùzza nìca vicìnu a lù màri e già l’aiutàvanu a scapisàri la rina. Trasèru nà la casermètta. Lù cchiù rànni di lì Trìnca, assideràtu e strimàtu, fu aiutàtu e purtàtu sùpra un mataràzzu. Trimàvanu tùtti pi lu frìddu, si scutuliàvanu e si ammantiddràvanu circànnu di quatilàrisi alla mènu pèggiu.
Si accustà, GiuvanBattista, a lu frati rànni cù nà frazzàta pi allintàri lu frìddu e lù trimùri. Ma nùn trimàva cchiù, Giuseppi, nun parràva cchiù, havìa lassàtu pi sèmpri stènti e suffirènzi, havìa truvàtu a la fìni la pàci tra li vràzza làrghi di lù Signùri, dòppu nà vìta di travàgghiu e di mùti lamènti. Nùn chiancìa GiuvanBattista, taliàva nà lu vuòtu, taliàva lu màri quagghiàtu, taliàva ma nùn vidìa e nùn parràva. Da sèmpri sapìa chi stù mistèri èsti fàmi sudùri e làstimi di sàngu. Da sèmpri. Pinsàva chi stù crudèli distìnu di li piscatùra, ogni jòrnu in agguàtu, ogni jòrnu a tintàri, havìa arrivàtu, a la fìni, ma nùn havìa vinciùtu. Nùn ci’ha sàppi, no, lu màlu fàtu, a tinìrisi lu còrpu nà lu fùnnu di lu màri. Ccà, era, ccà, lu corpu di sò fràti pì putìri accògghiri lù chiàntu e li ìra di dulùri di la mugghièri e di lu fìgghiu. Lu fjgghìu Ignàziu, trentènni, òrvu e paralìticu, chi putìa sùlu sèntiri la vùci e nùn vidìri la carìzza di la mànu di sò patri. Ora màncu chìstu. Chi havìa havùtu di tàntu assà na la sò esistènza pi fàri st’àutra pinitènza ? E la mugghièri Quinci Antunìna, di sissantatrì anni, còmu havìa a fàri ora pi campàri na l’ùrtimi sò ànni ? Nùn parràva lu fìgghiu Cìcciu, gniuniàtu, sfinùtu, ammantiddràtu, nun parràva Pètru Di Maria, arramazzàtu sùpra lu pavimèntu, accunutu e allannàtu, nun parrava lu figghiu Turi, arrunnatu e pigghiàtu da lu trimulizzu vicinu a lu patri, nùn parràvanu li finanzèri, alluccùti da tàli svintùra, nùn ciuciàva cchiù lu vèntu, nùn èra cchiù scuètu lu màri. Nùn fù un jòrnu còmu l’àutri, ddrù jòrnu di lu sèi di màrzu di lu milliottucentunuvantasètti.
L’annu milliottucentunuvantasètti, lu jòrnu nòvi di màrzu, alli ùri 8 di sìra la giùnta municipàli di Mazàra deliberò a favùri di Quinci Antunìna, di anni 63 e dI Trìnca Ignàziu, di anni trenta, nà largiziòni di liri cinquanta.
TRADUZIONE
Un giorno come gli altri
Erano a qualche miglio dalla riva di Capo Fedo i pescatori della paranza a vela "Divina Provvidenza". Un giorno come gli altri, quel giorno. Il cielo, anche se incerto e piagnucoloso, non sembrava ostile e i cinque marinai, taciturni e tristi da sempre per esperienze strazianti, da alcune ore lavoravano rimuovendo dalla rete pesci lucenti. Un giorno come gli altri, quel giorno del sei di marzo del milleottocentonovantasette. Silenziosi per indole, per destino o per fatti di vita vissuta, i pescatori svolgevano il loro lavoro senza profferire parola, se non per necessità. Anche il giovane Francesco, di appena diciassette anni, ma già da cinque aveva conosciuto le sofferenze di tale mestiere, ripeteva, senza muovere lingua, i gesti lavorativi del padre GiovanBattista Trinca, di cinquantaquattro anni, dello zio Giuseppe Trinca, di sessantaquattro anni, dell’amico Pietro Di Maria, di trentasette anni e del di lui figlio, Salvatore, ragazzo di dodici anni, che, da due stava assaporando le tribolazioni della vita di mare. Un giorno come gli altri, quel giorno.
Improvvisamente, in quel profondo silenzio, un lieve rumore. Videro, davanti a loro, non molto lontano, vento e acqua alzarsi a vortice, come una montagna, dal mare verso il cielo.
Atterriti, rivolsero immantinente il pensiero a San Vito, ma le parole non fecero in tempo ad uscire dalla bocca chè in un lampo furono scaraventati, dopo un volo di alcuni metri, nelle fredde acque del mare di marzo. Avvertivano l’acqua salata scendere nella gola, gli occhi spalancati bruciare, il sangue pulsare, le orecchie fischiare, mentre i corpi precipitavano verso il fondo. “No, no,” pensavano, “non dovevano cedere”. Strinsero i denti, spinsero con disperazione, con le mani e con i piedi, l’acqua verso il fondo e, mentre i corpi fluivano verso l’alto, intravedevano sopra la luce sempre più vicina. Come il sughero, dal fondo del mare, sale impetuoso all’aria e dopo ricade restando a galla, così i pescatori, mentre mostravano i primi segni di asfissia, emersero dall’acqua all’aria bramata e benedetta con la testa, con le spalle e con il tronco. Il padre, GiovanBattista, ancor prima di respirare, emise un grido angoscioso e lungo, Cìccioooo, alla ricerca dell’amato figlio, fino a quando non lo vide e non lo sentì tossire con gli occhi rossi e con la bocca aperta. Per un attimo il suo grido si incrociò con quello disperato di Pietro di Maria, Turiii. Si guardò intorno. Erano tutti a galla, Francesco, Giuseppe, Pietro, Salvatore, la barca capovolta, la vela e il timone rotti, tavole e pezzi di legno sopra il mare quietato. La tromba d’aria aveva bussato ancora per domandare e pretendere il suo consueto tributo. Con sforzi sovrumani i pescatori rovesciarono la barca, la svuotarono dell’acqua come meglio potevano, anche a mani unite, e tentarono di guadagnare la spiaggia a forza di remi. Ma la paranza, non completamente vuota, andava a rilento e le forze dei pescatori erano prossime all’esaurimento. Arrivati a mille metri circa dalla riva, decisero di abbandonare il loro mezzo di lavoro e di sopravvivenza e continuare a nuoto. Ma le acque gelide toglievano il fiato e l’energia e, ad un certo momento, le forze vennero meno. Le braccia erano piombo, il petto un blocco di ghiaccio, il cuore batteva come un orologio, la bocca aperta ed il fiato grosso. Erano ormai immobili i pescatori, come una calamita il fondo del mare li attirava. Si stavano arrendendo al fato prepotente quando sentirono voci di speranza: “resistete, resistete, stiamo per arrivare”. Erano i finanzieri di quella casetta vicino al mare e già li aiutavano a calpestare la sabbia. Entrarono nella casermetta. Il più grande dei Trinca, assiderato e stremato, fu aiutato e portato sopra un materasso. Tremavano tutti e si ammantellavano con coperte di fortuna.
Si accostò, GiovanBattista, al fratello maggiore con una coperta per allentare il freddo e il tremore. Ma non tremava più, Giuseppe, non parlava più, aveva lasciato per sempre stenti e sofferenze, aveva trovato, alla fine, la pace tra le braccia capienti del Signore, dopo una vita di lavoro e di muti lamenti. Non piangeva GiovanBattista, guardava nel vuoto, guardava il mare pacato, guardava ma non vedeva e non parlava. Da sempre sapeva che questo lavoro è fame, sudore e lagrime di sangue. Da sempre. Pensava che questo spietato destino dei pescatori, ogni giorno in agguato, era, alla fine, arrivato per suo fratello, ma non aveva vinto. Non era stato capace, no, il fato malvagio, di tenersi il corpo nel fondo del mare. Qua era, qua, il corpo di suo fratello per potere accogliere il pianto e le grida di dolore della moglie e del figlio. Il figlio Ignazio, trentenne, cieco e paralitico, che poteva solo sentire la voce e la carezza ma non vedere la mano del padre. Ora nemmeno questo. Che aveva avuto di così tanto nella sua esistenza per patire quest’altra penitenza ? E la moglie Quinci Antonina, di sessantatrè anni, come doveva sopravvivere, adesso, negli ultimi suoi anni ? Non parlava il figlio Francesco, sfinito, ammantellato e accovacciato in un angolino, non parlava Pietro Di Maria, rannicchiato sul pavimento, tremante e istupidito, non parlava Salvatore corrucciato, in preda ai brividi di freddo e accoccolato accanto al padre, non parlavano i finanzieri, sconvolti da tanta tragedia, non soffiava più il vento, non era più inquieto il mare. Non fu un giorno come gli altri, quel giorno del sei di marzo del milleottocentonovantasette.
L’’anno milleottocentonovantasette, il giorno nove di marzo, alle ore otto di sera, la Giunta Comunale di Mazara deliberò a favore di Quinci Antonina, di anni 63 e di Trinca Ignazio, di anni trenta, una elargizione di lire cinquanta.